"Quando sono lì, guardo" - intervista a Claudio Gregori

A pochi giorni dall'inizio del Giro d'Italia vi proponiamo in versione digitale l'intervista a Claudio Gregori realizzata nel settembre del 2018 da Filippo Cauz e Riccardo Spinelli, e pubblicata per la prima volta all'interno del volume "Chissà che l'utopia non vinca".
Claudio Gregori è un autore con uno spiccato gusto per il dettaglio e la ricerca, e i suoi pezzi “d’altri tempi” hanno segnato trent’anni di giornalismo sportivo italiano. Questo è il resoconto di un pomeriggio passato insieme a lui, a chiacchierare di tutto quanto è possibile raccontare con la "scusa" delle biciclette.
Le indicazioni per arrivare a casa Gregori non sono semplicissime da seguire. Bisogna uscire dall’autostrada pochi chilometri a sud di Milano, poi procedere tra i campi in direzione Ticino stando bene attenti a non farsi distrarre dagli aironi che si alzano in volo dai canali.
Il centro di Torre d’Isola, quest’entità geografica che in realtà è soltanto il frutto della progressiva aggregazione di villaggi più minuscoli e dispersi, è come tutti i centri dei piccoli comuni di campagna: la chiesa, il municipio, l’osteria.
Potrebbe essere lo scenario ideale in cui ambientare una storia antica, l’avventura di un corridore partito in bicicletta dai campi e arrivato sul tetto del mondo. Una di quelle storie che il padrone di casa che stiamo cercando di raggiungere saprebbe ricostruire con minuzia di particolari, individuando un riferimento utile in ogni mattone, albero o airone lungo la strada.
Riassumere in poche parole chi sia Claudio Gregori, 73 anni e un’infinità di storie da raccontare, è impresa ardua. La sua carriera come giornalista e scrittore è lunga e tortuosa come un sentiero di montagna. Dopo una breve parentesi da calciatore e una laurea in matematica, dal 1974 si è dedicato al giornalismo sportivo, occupandosi di nuoto, calcio, atletica, motori, pallavolo e ciclismo – soprattutto ciclismo.
La strada di Bidon e quella di Gregori si sono incrociate nel segmento più recente della sua traiettoria, quando, folgorati dai suoi libri dedicati a Luigi Ganna, Eddy Merckx e Ottavio Bottecchia, abbiamo provato a lanciarci al suo inseguimento. Dopo averlo convinto a scrivere la prefazione di Se qualcuno viene ci fa piacere e alcuni racconti de il Centogiro, abbiamo deciso di tornare a trovarlo per chiacchierare con lui senza limiti di spazio e di tempo. Un’utopia di intervista, si potrebbe dire.
Claudio Gregori non poteva abitare in un luogo diverso da Torre d’Isola. Lo sorprendiamo al telefono con la voce un po’ affaticata: più che dalla digestione, dalla cronometro iridata di Innsbruck, seguita in tv senza celare gli sbadigli.
A casa sua ci sono dei lavori in corso: un muratore ha staccato le finestre per sistemare gli infissi, la moglie ne ha approfittato per fare un giro a Genova a trovare la nipotina. Claudio e la sua enorme gatta ci aspettano.
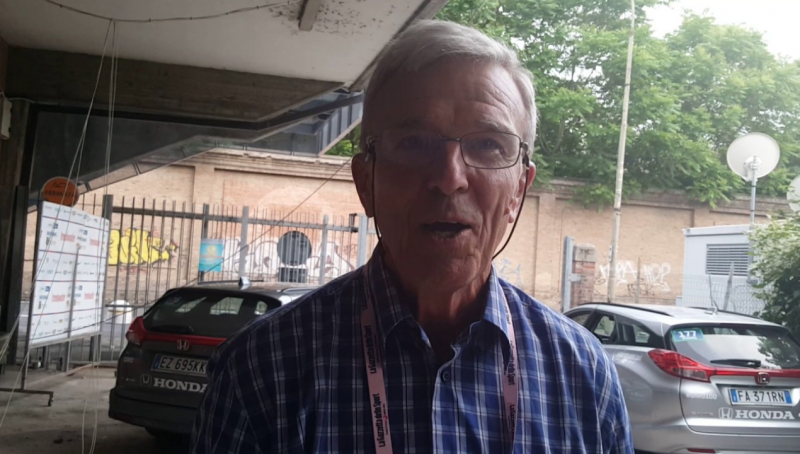
B: Caro Claudio, due anni fa incontrammo Gianni Mura alla vigilia del Tour, oggi incontriamo te alla fine della stagione 2018. Cominciamo dallo stesso punto, però, tanto è comunque un gioco di fantasia. Domani parti per il tuo primo Giro d’Italia: cosa ti aspetti?
CG: È difficile come domanda iniziale, questa. Perché il Giro per me è stata una sorpresa. Quel che ho scoperto è che la corsa diventa un pretesto per conoscere il paesaggio e la storia d’Italia. Quando sono partito per il mio primo Giro d’Italia, era il 1985, non me l’aspettavo. Vi faccio un esempio: le viti. Parti dalla Sicilia e vedi le viti ad alberello alte 40 centimetri. Vieni su e vedi il paesaggio viticolo che cambia, arrivando fino alle grandi viti a spalliera dell’Alto Adige, e queste sono enormi, completamente diverse. Il Giro è bellissimo perché è una lezione di geografia, di storia, di letteratura, di scienze naturali.
Se potessi ricominciare da zero la tua carriera di inviato, cosa faresti?
Quello che ho fatto. A Certaldo andrei a vedere la casa di Boccaccio. In Sicilia andrei a vedere i luoghi di Pirandello e il teatro greco di Taormina. A Pæstum andrei a vedere la tomba del tuffatore, che con il Giro all’apparenza non c’entra niente… Ma io mi occupo anche di nuoto ed è una cosa interessante, non si sa mai.
Andrei a vedermi la casa di Benedetto Croce, i luoghi di Carducci e quelli di Pascoli. Andrei a nuotare, cercherei di vedere tutto il possibile. E non è solo questione di Giro, è così il ciclismo tutto: quando mi hanno mandato al Giro di Turchia, sono andato a visitare i luoghi della guerra di Troia, ed è stato bellissimo. Ho sempre scritto pezzi di colore, che ti danno la scusa per essere un po’ più libero, per muoverti. Scriverei ancora quelli, dunque, e cercherei di imparare di più.
Secondo te, perché quasi nessuno scrive più pezzi di colore?
Non entro nella testa altrui, ma penso sia perché è più semplice fare altro. Stare in corsa è faticoso, la maggior parte dei giornalisti non fa più il percorso se non è obbligata. Se c’è l’autostrada, va dalla partenza direttamente al traguardo e vede la tappa in sala stampa davanti alla tv, come si vede da casa. Certo, la corsa così la vedi meglio. Perché se attaccano nel bosco e tu sei sulla salita, difficilmente sei nel punto giusto, senti solo Radiocorsa che dice che hanno attaccato.
Poi una volta in cima alle salite devi partire velocissimo, altrimenti i corridori ti raggiungono. È capitato anche a noi più volte: il nostro autista Gigi, detto l’auriga, in discesa doveva andare come una scheggia per non essere superato.
Ha ancora senso stare fisicamente sulla strada?
Sapete, la tv mostra tutto, anche di più, ma se fai il percorso vedi tante altre cose. Prendete il Colle delle Finestre. La prima volta che l’ho fatto, ho scritto degli indiani che erano in cima. Ed erano proprio come gli indiani, tutta ’sta gente in cima alla montagna che guardava giù. La televisione ti offre immagini belle, ma se il Colle delle Finestre lo scali per davvero allora ti rimane il senso del percorso, del bosco che a un certo punto si apre, di questa salita che va su, del pubblico in cima che punteggia la strada, dello sterrato.
Se dovessi scegliere una tappa in cui è stato importante “esserci”, quale diresti?
Gavia 1988. Cannavò la mattina mi disse: ‘Claudio, vai sul Gavia. Li fai passare tutti e poi racconti quello che vedi’. Nevicava. Salii su con il mio autista in preda al panico, non riusciva ad andare su. Al traguardo arrivammo dopo l’ultimo corridore. Quella volta credo di aver battuto tutti, ma non perché fossi bravo o chissà che; semplicemente perché ero lì. La televisione quel giorno non diede grandi immagini, io invece in cima al Gavia vidi l’incredibile.
Vidi van der Velde passare su con le maniche corte, come era partito, con la neve sui capelli. Vidi Piasecki con le stalagmiti di ghiaccio che pendevano dai baffi, in condizioni pietose, e Pietro Algeri, il suo direttore sportivo, che lo buttò in macchina e con una coperta cercava di massaggiarlo. Dalla macchina si sentiva un solo rumore sinistro e fortissimo: era il rumore dei denti di Piasecki, un rumore che non ho mai più sentito. In discesa trovai un corridore in piedi come Cristo in croce: era lo spagnolo Ibáñez Loyo, con quattro samaritani che gli massaggiavano le braccia e le gambe.
E poi vidi Mächler, che aveva vinto la Sanremo e scendeva con la bici a mano. Gli rivolsi la parola e lui mi rispose. Ma non capiva, non vedeva, non sapeva. Andava giù a piedi per scaldarsi ma non stava più correndo, non stava più pensando alla corsa. Era un automa. Più giù dentro una macchina c’era Cesare Cipollini, il fratello maggiore di Mario, che piangeva mentre il suo meccanico cercava di convincerlo a continuare. ‘Dai Cesare che è finita’, e quello piangeva.
L’ultima persona che vidi fu Shelly, una fisioterapista che ci fermò dopo aver visto la macchina Gazzetta. Stava cercando ancora una corridore, Gagne, e io provai a rassicurarla dicendole che dietro di noi non c’era più nessuno. Sul Gavia trovai l’eroismo dei corridori, la sfida al dolore che rende grande la corsa. Il pezzo che scrissi cominciava con: “L’Inferno è qui”.

Non è che semplicemente oggi a nessun inviato viene chiesto il tipo di pezzo che veniva chiesto a te?
Quando uno scrive ha libertà. Se poi uno ha anche talento e idee, fare il pezzo di cronaca è ridicolo, essendoci già la televisione. Scrivendo della corsa devi per forza avere un approccio diverso, e il ciclismo è una miniera da questo punto di vista. Ci sono personaggi incredibili, anche i piccoli del gruppo hanno storie interessanti.
Per esempio?
Una volta ero a una di quelle partenze di tappa dove i bus sono spalmati per chilometri. Ero in fondo, davanti a quello della Katusha, di altri giornalisti neanche l’ombra. C’era Zakarin ben messo in classifica generale, ma di lui si sapeva poco. Il fatto che vivesse a Cipro mi incuriosiva, così mi dissi ‘andiamo a vedere’. Zakarin è uno che non parla con nessuno, ma Konyshev sì, allora chiesi a lui di farmi da traduttore.
Parlammo un po’ e venne fuori che Zakarin era musulmano. E io su quello costruii l’attacco del pezzo, dicendo che al Giro ci trovi ragazzi di tutte le religioni: c’è il giapponese che è scintoista, il russo ortodosso, l’ebreo, l’ateo, il cattolico, il protestante, c’è tutto. Questa storia che era musulmano non era mai venuta fuori prima. Ci vuole curiosità, tutto qui.
Non è facile, però. Tante volte i corridori fatichi anche solo a incrociarli.
Per quello va colta l’opportunità! Altro esempio, la tappa di Castellania del Giro 2017. La partenza quel giorno è molto complicata, perché bisogna parcheggiare a valle e salire con l’autobus. Ma io devo fare il pezzo di colore, e non posso non andare a Castellania, così arrivo su prestissimo. A un certo punto un mio collega sta per intervistare Dumoulin e io gli dico: ‘Guarda che Dumoulin è uno sveglio, digli che a meno di 100 metri da qui c’è la tomba di Coppi’. Nel frattempo cerco di aprire le transenne e avverto le forze dell’ordine. Dumoulin, da parte sua, si lascia incuriosire e viene.
Poi, il colpo di fortuna: nel pomeriggio Dumoulin stacca tutti e vince ad Oropa. Allora io comincio il pezzo rispolverando il Foscolo: “A egregie cose il forte animo accendono, l’urne de’ forti”, che è un attacco dotto e palloso ma assolutamente pertinente, perché la maglia rosa al mattino va alla tomba di Coppi, ne trae ispirazione e più tardi fa “il Coppi”. Il giorno dopo i giornalisti americani volevano ricostruire tutta la vicenda.
Ecco: questo in sala stampa non sarebbe mai potuto succedere. Invece sulle strade incontri il mondo e gli uomini. È una cosa anche un po’ filosofica, se vogliamo.

Quindi c’è ancora spazio per il tuo tipo di racconto nel ciclismo di oggi?
Secondo me c’è spazio, e bisogna rispolverarlo. Adesso andiamo verso una tecnica di informazione basata sulla rapidità, e la rapidità non si sposa con la poesia, con l’osservazione, con la ricerca. Vedi una cosa, tan tan tan e mandi il pezzo. Quel pezzo lì non passerà alla storia, quella è roba che deve fare l’agenzia. Tu devi trovare una chiave. Vai ad Innsbruck e devi conoscere cosa è successo lì, devi sapere delle Olimpiadi, cose che apparentemente non c’entrano niente ma poi tornano utili. Vai al Mont Ventoux e lo devi conoscere, devi sapere di Petrarca, cosa ha scritto nel 1336.
E devi andare su e vedere, e sapere: perché non ci sono le piante anche se siamo soltanto a 1900 metri? Perché cresce solo vegetazione strisciante, queste specie artiche lasciate dall’era glaciale? Non puoi andare lì e raccontare solo la corsa. Devi sapere che c’è il maestrale che arriva a 260 all’ora, devi andare alla stele di Tom Simpson. Non puoi andare sulle Dolomiti e ignorare che lì 200 milioni di anni fa c’era il mare. Vedi le rocce vulcaniche e devi collegarle al fatto che c’erano anche i vulcani, quindi era un posto estremamente violento.
Insomma, il primo strumento per conoscere è sempre guardarsi intorno.
Nella macchina della Gazzetta tutti mi prendevano in giro perché durante il percorso magari esclamavo ‘Oh, ho visto un’orchidea!’. Per non parlare poi delle marmotte… La volta che Ivan Basso è andato in crisi sullo Stelvio, ed è arrivato con più di 20 minuti, lo seguivamo solo noi. Ormai erano passati tutti, e lungo la discesa c’erano le marmotte che attraversavano la strada. Tutti i miei colleghi si stupirono della visione. Ma il ciclismo è anche lezione di cultura naturalistica.
Sembra di capire che tu studi sempre un sacco prima di partire per una corsa…
Sì, oppure mi preparo un po’ lì. Se il Giro parte in Sardegna, mi preparo sulla civiltà nuragica. Poi, quando sono lì, guardo. L’occhio è uno strumento fondamentale, lo devi educare, renderlo capace di riconoscere un’orchidea e di scovare una marmotta. Puoi anche scrivere, senza vederla, che sul Gavia un’aquila volteggia, perché presumibilmente c’è. Ma se riesci a distinguerla coi tuoi occhi è diverso! Perché alla fine è il mondo il campo di gara del ciclismo. Vedete, io da calciatore ho giocato anche a San Siro, al vecchio Appiani di Padova, al Flaminio. Certi stadi sono bellissimi, San Siro è impressionante. Però il Pordoi è più bello.

Il tuo terreno d’elezione, è evidente, è l’ambiente. Ma ce n’è un altro estremamente importante: la relazione con le persone. Com’è cambiato nel tempo il rapporto con i corridori?
La possibilità di rapporto è ovviamente regredita, ma il ciclismo è ancora lo sport in cui hai più facilità di contatto. Mi ricordo una volta Piepoli che a fine tappa tremava dal freddo, era stremato, ma si fermò a parlarmi. Purito Rodriguez, uscito dall’ospedale tutto ingessato dopo una tappa in cui si era fratturato, uguale: se avessi avuto bisogno di 20 minuti, lui sarebbe stato lì 20 minuti. Questo lo puoi fare solo con i corridori, non lo puoi fare in nessun altro sport. Quelli che fanno barriera a volte sono gli uomini delle squadre. Mi è capitato di incontrare degli addetti stampa davvero cretini, che dimostrano di non conoscere la nostra professione.
Qual è stato il corridore con cui è stato più piacevole chiacchierare?
Un ex-corridore, all’epoca, Gino Bartali. Tra gli anni ’80 e ’90 io dovevo fare i pezzi di colore e Bartali era sempre al Giro. Quando arrivavano le montagne, Cannavò mi chiedeva sempre di fare un pezzo con lui. Ho fatto una quindicina di tappe in tutto sulla macchina di Bartali, perché lui non voleva mai venire sulla mia. La tappa con Gino iniziava mezz’ora prima della partenza, e mezz’ora dopo l’arrivo lui era ancora lì che parlava. Con lui si è creato un rapporto bellissimo, di assoluta amicizia. Sembrava così rustico, ma era un compagno divertente.
Ti raccontava un sacco di cose: alcune anche strane però tutte vere, perché la bugia per lui era peccato. Bartali mi ha raccontato la vicenda degli ebrei, ma non me l’ha raccontata come una prodezza. Me l’ha raccontata perché è venuta fuori passando per Assisi, dove, sapendo che ero trentino, mi chiese se conoscessi monsignor Nicolini. Così iniziammo a mettere insieme i pezzi e, un po’ con le tenaglie, gli tirai fuori la storia.
Alla fine gli dissi: ‘Gino, su questo ci facciamo una pagina’. Ma lui mi prese la mano – tanto guidava sempre con una mano sola, era pericolosissimo – e mi disse la sua solita frase: ‘No, Claudio, tu non scrivi niente. Perché il bene si fa ma non si dice’. E io non scrissi. Un’esperienza del genere è forte, esci dalla macchina e dici: ‘Però, questo qua è un grande’.

Quali sono i presupposti per una buona intervista?
Il giornalista deve essere serio, cercare la verità. Deve restare sempre umano, sia chiaro, ma la sua umanità deve passare attraverso il crivello della verità. Il giornalista che si occupa di ciclismo deve affrontarlo in ogni suo aspetto: bisogna scoprire che il ciclismo non è un paradiso, c’è anche la componente infernale.
Il discorso di fondo è semplice: non è assolutamente vero che il ciclismo è uno sport bestiale che pretende l’uso del doping. Questo è falso. Il mio ultimo libro è su Bottecchia, e se guardate le tappe di quegli anni ce n’erano anche di 482 chilometri. Il Tour di Bottecchia era lungo 5700 chilometri, con tappe pazzesche, ma si riusciva a farlo senza arsenali farmaceutici. Semplicemente andavano più piano. Dove sta scritto che bisogna andare a 52 all’ora?
Quindi il ciclismo per inventarsi il suo futuro deve guardare al passato?
Il ciclismo deve innanzitutto far rispettare le regole, che ci sono. Se ci si accorge che sono regole inadeguate si possono migliorare, ma poi vanno fatte rispettare. Dopodiché l’importante è non fossilizzarsi. Io per esempio lascerei libertà totale agli organizzatori di trovare dei percorsi creativi. Fai la cronoscalata a Plan de Corones, vai sul pavé, fai la tappa di 400 chilometri. Basta osare, per avere la possibilità che venga fuori una gara bellissima.
E dell’uso/abuso tecnologico cosa ne pensi?
Ecco, questo è un discorso che avrei dovuto tirare fuori prima. La tecnologia cancella l’individuo e deprime la corsa, le toglie la fantasia individuale. Oggi vengono dati ordini chilometro dopo chilometro, viene fermato anche chi potrebbe andare all’attacco. Mi viene in mente l’esempio di Kwiatkowski al Tour de France. Compiti così rigidi rischiano di sminuire i talenti, invece bisogna ridare al corridore lo spazio per la creatività che non ha più. Lo scontro tra i campioni non può appiattirsi al solo piano fisico.
Se ci fosse la possibilità di togliere misuratori di potenza e radioline, lo farei subito. Io non sono contro la modernità, sia chiaro, ma l’atleta i suoi dati li misura in allenamento. Mi viene da ridere quando sento uno che dice che in salita si è fermato perché aveva raggiunto quei watt e non poteva rischiare oltre. Una volta era proprio il fuorigiri a dare la svolta della corsa, perché oltre a te magari andava fuorigiri anche l’altro. Quindi sì, lascerei i numeri fuori dalla corsa.
Anche dal racconto della corsa? Tu sei un uomo di numeri, sei laureato in matematica, eppure il tuo racconto è incentrato del tutto sulla parola.
Certamente, lascerei la tecnologia fuori anche dal racconto. Poi, certo, se uno va a 800 watt lo devi scrivere, e ti devi anche preoccupare. Ma a dare i numeri ci pensano già tanti. Io l’ho fatto per anni col calcio ed ero considerato il terrore dei giocatori di fantacalcio, perché usavo tutti i voti. Ho dato degli 1 come dei 9, e cercavo di usarli sempre in buonafede. Se Maradona non toccava palla, beccava 4 come Bruscolotti. A Del Piero non davo mai 5.5, che è un voto codardo. Ma questo è irrilevante, io non sapevo nemmeno come funzionasse il fantacalcio, non ci ho mai giocato.
A calcio invece hai giocato. Com’è stata la tua carriera?
Direi ridicola. Però credo di essere stato l’unico ad aver saltato un provino col Milan per andare a fare un esame all’università. Avevo anche provato a spostarlo, ma era il mio primo esame, analisi matematica, e il professor Cinquini era uno che il lunedì veniva a far lezione con la cravatta dell’Inter. Provai a farmi concedere un rinvio, ma quando Cinquini scoprì che era per il Milan non ne volle sapere. Comunque all’esame salvai la pelle e presi 24. Tutto sommato credo di aver fatto la scelta giusta.
Non sarà mica finita in questo modo la tua carriera di calciatore…
No, dopo ebbi altre possibilità. Giocai un’amichevole col Mantova in B, contro la Reggiana, giocatori veri della categoria. Ero completamente fuori allenamento, eppure nel secondo tempo a un certo punto mi presentai solo davanti al portiere avversario, che in quell’occasione era il mitico Boranga. Ci arrivai nel modo ideale, col piede ideale, mi dissi ‘gliela metto là’ e invece venne fuori uno straccio bagnato. Ciononostante l’allenatore del Mantova mi avrebbe voluto prendere, a patto che mi fossi trasferito nel loro collegio, cosa impossibile per me che a Pavia dovevo frequentare i corsi e dare gli esami.
Infine, dopo la laurea, mi fece un’offerta il Bolzano e, siccome volevo tornare a casa per stare vicino a mia madre malata, accettai e mi trovai una supplenza in un liceo in città. Nella terza avevo tra gli alunni il mio portiere, che era un asinone, bocciato tre volte. Avevamo un allenatore brasiliano: si chiamava Augustine, e quando vide che ero forte di testa mi disse ‘Tu juge stopper’, l’unico ruolo che non avevo mai fatto – oltre al portiere. Poi iniziarono scuola e campionato e lui mi disse: ‘Tu no juge’. Quando lo cacciarono feci tre partite e due gol, un’ottima media.
Fu allora che mi avvicinò uno del Vicenza, che era in serie A, ma io ormai facevo altro. Avrei ripreso a giocare anni dopo con la nazionale dei giornalisti, con cui nel ’75 al Flaminio sfidammo la nazionale cantanti e attori. Noi avevamo in panchina Liedholm, che mi disse di marcare Pasolini ma di lasciargli comunque spazio. Lo marcai a 8-10 metri. La seconda partita fu a inizio ottobre, e fu l’ultima di Pasolini. Un mese dopo venne ammazzato.

A questo punto, dopo essere stato calciatore e professore di matematica, sorge il dubbio riguardo cosa sia successo per farti diventare giornalista.
Accadde mentre insegnavo esercitazioni di analisi matematica all’università di Trento. Era un periodo di grandi assunzioni, quindi prima o poi sarei entrato di ruolo. Ma era anche il ’68, e io vedevo delle capre pazzesche passare gli esami: una cosa che non riuscivo proprio a digerire, io che sono sempre stato per la scuola selettiva. Così un giorno questo mio amico napoletano, Giorgio Tutino, che scriveva per un settimanale di sport a Roma, sapendo che ero esperto di montagna e sport invernali mi propose di collaborare con loro. E così cominciò tutto.
Andai a fare una prova al Tempo, dove era appena arrivato come direttore Gianni Letta e c’era una grossa riorganizzazione in redazione. Poco tempo dopo mi richiamarono e mi trasferii a Roma. A fare tutto. Perché voi mi considerate un giornalista di ciclismo, ma in realtà io ho avuto la grande fortuna di coprire ogni sport. Ho cominciato dal nuoto, non per scelta ma perché quello mi han chiesto: mi sono abbonato alle riviste specifiche, ho cominciato a frequentare le piscine e ho fatto il mio primo servizio da inviato, ai campionati italiani a Padova.
Quindi è un’attitudine che hai da sempre, quella di metterti a studiare tutto. Ci sono tuoi colleghi che ti considerano archeologo più che giornalista, per la dedizione con cui esplori ogni archivio e ogni microfilm.
Vado a vedere la storia. Quando leggo il nome di un corridore che non conosco mi viene immediatamente la curiosità. Cercando su internet non trovi tutte le risposte, così mi dico ‘andiamo a vedere’. E mi diverto come un pazzo.
Per esempio, facendo il libro di Bottecchia ho scoperto che ha vinto una tappa sul rettilineo dove Monet dipinse il quadro che ha dato il nome all’impressionismo. Sono andato a controllare e tutto corrispondeva: era “Impression, soleil levant”, ed era proprio lì, al porto di Le Havre, dove Bottecchia aveva vinto la prima tappa del Tour del ’24. Capisco che ad altri miei colleghi Monet non interessi molto, però quando l’ho scoperto per me è stato un giorno positivo.

Per immergerti a fondo negli archivi però hai dovuto aspettare gli anni della Gazzetta, giusto?
Dopo il Tempo sono andato al Messaggero, poi al Giornale, quando c’era ancora Montanelli e aveva all’ingresso del suo ufficio un merlo indiano che aveva imparato le sue imprecazioni e insultava tutti quelli che entravano. Le Olimpiadi sono state la mia grande palestra: a Mosca ’80 ero l’unico inviato del Tempo, ed è stata un’esperienza davvero allenante. Per dire, in una giornata ho coperto cinque sport diversi. Ero l’unico che usava la metropolitana, perché gli organizzatori preferivano tenere i giornalisti su mezzi dedicati, ma io ero abituato ad andare in montagna e a camminare chilometri – e la metropolitana di Mosca oltretutto è bellissima.
Così in un giorno ho fatto un quarto di finale di Mennea, la partita del Settebello, la prova in linea di ciclismo vinta da Suchoručenkov, la finale di canoa e la scherma della Vaccaroni, che si sperava vincesse e invece finì sesta o settima. Alla Gazzetta ci sono arrivato più tardi, nel 1986. Mi chiamò Gino Palumbo, nonostante non ci conoscessimo: leggeva i miei pezzi e gli piacevano. Sul momento tentennai un po’, perché al Giornale mi trovavo bene, ma Montanelli ormai andava per i novanta e la Gazzetta mi dava più sicurezze per il futuro. Infatti ci sono rimasto oltre trent’anni, fino all’estate scorsa.
L’ho conosciuta bene, la Gazzetta, e ho conosciuto bene il suo archivio, dove in pratica andavo solo io. Ho incontrato giusto Garlando qualche volta. Il mio approccio era quello di considerare lo sport come una scienza, facendo ricerca seriamente, ed è lo stesso che uso ancora.
Per curiosità, ma anche per evitare errori.
Di errori ne fai comunque tanti. Per dire, nel libro di Bottecchia ho scoperto un errore sullo spagnolo che mi fa ancora incazzare, anche se la gente non se ne accorge. Ho confuso quebrantahuevos, cioè “rompiuova”, con quebrantahuesos, cioè “rompiossa”. Avevo paragonato Bottecchia al grifone, che è un quebrantahuesos perchè si nutre di cadaveri e non tralascia nemmeno le ossa: le porta in alto e le fa cadere sulle rocce per poi mangiare il midollo. Io invece nel libro ho scritto quebrantahuevos, ed è una cagata.
Ad ogni modo, la tua passione è sempre stata ripagata.
Assolutamente sì. Mi sono divertito e mi è capitato di fare dei servizi incredibili. Al Giro di Polonia ho convito Cataldo e Bennati a visitare Auschwitz con me: vedere un giovane grosso e forte come Bennati commuoversi nella sala docce è stata un’emozione incredibile.
A Los Angeles invece mi è capitato di fare un’intervista di un’ora a Pavarotti. Pavarotti era uno che le interviste non le concedeva, ma per via della sua passione per i cavalli era diventato amico della Gazzetta.
Alle Olimpiadi di Seoul ho intervistato l’ultimo tedoforo, che mi fece togliere le scarpe prima di parlarmi, e io avevo l’alluce che mi aveva bucato il calzino. La sua era una storia assurda: aveva corso le Olimpiadi quando la Corea era invasa dai giapponesi, quindi con il simbolo del Giappone sulla maglia. Tuttavia il più grande giornale coreano come protesta cancellò il simbolo, e lui venne arrestato. Storie simili non vengono fuori, se stai lì come un pesce lesso allo stadio.
E poi la storia più incredibile di tutte, quella con Kornelia Ender. Andai a fare un’inchiesta sul doping in Germania Est, arrivai e mi diedero una Trabant, una baracca pazzesca, e via. Feci un’intervista lunga e bellissima con Kornelia, la miglior nuotatrice dell’epoca, poi però lei mi chiese di non scrivere nulla finché non si fosse trasferita ad Ovest. Quindi mi tenni il pezzo dentro per cinque mesi, finché lei non mi richiamò da Magonza: Cannavò ci fece cinque pagine.
Si comincia con lo sport e si finisce parlando della storia a tutto tondo.
Una volta ho scritto persino un pezzo per il Presidente del Consiglio. Erano i mondiali di calcio del 2006, e la Gazzetta voleva un pezzo di Prodi diretto alla Merkel, alla vigilia di Germania-Italia. Io ero al giornale a fare ricerche quando arrivò un vicedirettore disperato perché cercava da tre giorni il contatto con Prodi ma non riusciva a parlarci, così chiese a me. Gli dissi che conoscevo uno che andava in bici con lui, il figlio di Cimurri, il massaggiatore di Coppi.
Provai a chiamare questo Cimurri e sentii che aveva il fiatone. Gli spiegai la cosa e lui: ‘Prodi è qui che pedala con me, glielo dico’. Dopo un’ora mi chiamò Prodi. Gli dissi che il giornale voleva un pezzo sui suoi ricordi di Italia-Germania 4-3, e per andargli incontro gli proposi di raccontarmi la sua versione e di scrivere io una bozza da mandargli, dato che poi il pezzo sarebbe uscito a firma sua. Andò così. I colleghi durante quella telefonata mi guardarono come un marziano, perché trattai il Presidente del Consiglio come un ciclista. Alla fine il pezzo a lui piacque, non accettò soltanto il mio incipit: “Cara Angela…”

Se avessi la possibilità di fare un ultimo servizio da inviato, dove andresti?
C’è un continente meraviglioso e disprezzato che è l’Africa. Ma non ci andrei solo per lo sport, eh. Una volta mi hanno mandato in Etiopia per un servizio su Gebrselassie: andai all’amba dove si allenava, e lì vidi le donne che scendevano dall’altura, che facevano ore ed ore per portare a casa una minuscola fascina di legna, quella che permetteva di mangiare. Ho visto gente che non si reggeva in piedi per la fame, gettata nei canaletti, però ho visto anche l’Africa più vera, con i suoi aromi e i suoi panorami. Ma questo è un discorso puramente teorico, perché, dopotutto, a chi interesserebbero questi pezzi? Era un giornalismo costoso, oggi nessuno può più permetterselo. Eppure andrebbe riscoperto.
Domanda finale, a bruciapelo. Non vogliamo rovinare il gusto della scoperta ai lettori, però nemmeno il tuo “Corno di Orlando” (66thand2nd, 2017) arriva a una verità finale sulla morte di Bottecchia. Puoi svelarci qui chi l’ha ucciso davvero?
Io alla fine lascio che sia il lettore a decidere. Bottecchia è stato un corridore grandissimo, è partito da ultimo dei gregari e in quattro anni ha raggiunto i massimi risultati. Poi è morto. In mezzo ha portato la maglia gialla per 34 giorni, più di Bartali e Coppi. Bottecchia era un eroe ed era un uomo chiuso come uno scrigno, conviveva con il mistero. E difatti il mistero è quello che resta. Diciamo che complessivamente il mio lavoro avvalora un po’ di più l’ipotesi dell’omicidio politico: c’erano grandi legami tra la morte del fratello di Bottecchia e uno dei massimi gerarchi fascisti. C’erano di mezzo dei soldi.
In più Bottecchia era uno che frequentava i circoli operai, ha avuto a che fare con i vermi che hanno ammazzato Matteotti, che ai tempi erano operativi in Francia. Nel libro metto in luce una situazione molto complessa, nella quale il delitto era una delle soluzioni praticabili. Ma nulla è certo. Bottecchia sul letto di morte parlò di una banale caduta ad alcuni testimoni, ma secondo me è perché era lucido abbastanza da capire che l’assicurazione avrebbe pagato sua moglie solo in caso di incidente.
Quindi, dopo anni di ricerca, il mistero resta aperto. Come dire: c’è ancora spazio per immergersi nella ricerca. Possiamo dire “obiettivo raggiunto”, per te?
Obiettivo raggiunto, assolutamente. Ora però posso offrirvelo un bel bicchiere di vino?

A cura di Filippo Cauz e Riccardo Spinelli. La foto di copertina è di Tornanti.cc




 Twitter
Twitter Facebook
Facebook Google+
Google+